Il Fascino del Sake Kimoto: Una Guida Completa alla Tecnica Antica
Il Kimoto è uno dei metodi più antichi e affascinanti per produrre sake. Nato oltre 300 anni fa, rappresenta la via tradizionale che ancora oggi alcuni produttori artigianali giapponesi portano avanti con passione. In questo articolo scopriamo cos’è il Kimoto, come funziona la sua fermentazione, le differenze rispetto al metodo moderno Sokujo e quali caratteristiche sensoriali rendono un sake Kimoto così speciale.
Cos’è il metodo Kimoto?
Quando si parla di sake artigianale, uno dei termini più ricorrenti è Kimoto 生酛. Si tratta di un metodo di produzione sviluppato nel periodo Edo, oltre 300 anni fa. Il suo scopo è creare il moto (o shubo), il piede di fermentazione, in un ambiente dove il lievito possa crescere in modo sicuro e vigoroso.
La peculiarità del Kimoto sta nell’assenza di scorciatoie: invece di aggiungere acido lattico dall’esterno (come accade nel metodo moderno Sokujo 速醸), si permette che siano i batteri lattici naturali a svilupparsi spontaneamente. Sono loro a proteggere la fermentazione, creando un ambiente stabile per il lievito.
Yamaoroshi: il cuore del Kimoto
Lo Yamaoroshi 山卸し, è la fase più iconica e faticosa della produzione Kimoto. Si tratta di un lavoro che ha reso questo metodo famoso per la sua difficoltà: due operatori lavorano in coppia, pestando e mescolando riso cotto a vapore e koji all’interno di grandi tini, con strumenti simili a remi da barca.
Questa operazione veniva svolta tradizionalmente di notte, durante i mesi più freddi dell’anno, proprio perché il freddo naturale favoriva lo sviluppo dei microrganismi giusti e riduceva il rischio di contaminazioni. Era quindi un compito massacrante: fisicamente estenuante e distribuito in più turni, in condizioni climatiche rigide.
Ma perché lo Yamaoroshi era così importante?
-
Permetteva di ottenere una miscela omogenea tra riso e koji.
-
Creava le condizioni ideali perché i batteri lattici naturali, provenienti dall’ambiente della cantina, proliferassero.
-
Grazie all’acido lattico prodotto, si eliminavano batteri indesiderati e si proteggeva la coltura del lievito.
Il risultato era la formazione di un piede di fermentazione (moto) sano e vigoroso, che costituiva la base di tutto il processo. Questo passaggio richiedeva circa tre o quattro settimane, ma garantiva un sake finale più ricco, complesso e morbido.
L’evoluzione moderna dello Yamaoroshi
Oggi pochissime cantine praticano ancora lo Yamaoroshi tradizionale. Alcune hanno introdotto tini in acciaio inox per maggiore igiene, altre ricorrono a mescolatori elettrici o persino a sistemi in cui i Kurabito (artigiani impegnati nella produzione del sakè) pestano il riso con stivali speciali.
Non esistono regole rigide su quanto il riso debba essere frantumato: la difficoltà sta proprio nel trovare il giusto equilibrio. Se il riso diventa troppo colloso, infatti, rischia di ostacolare la crescita del lievito. Per questo lo Yamaoroshi viene ancora considerato un’arte di precisione, più che una semplice tecnica manuale.
Kimoto vs Sokujo: le differenze principali
Con l’introduzione del metodo Sokujo nel XX secolo, la produzione di sake è diventata più rapida e sicura. Tuttavia, le differenze tra i due metodi sono sostanziali:
-
Tempo e pazienza: il Kimoto richiede almeno 4 settimane per sviluppare il piede di fermentazione, contro le 2 settimane del Sokujo.
-
Acido lattico: nel Kimoto si forma naturalmente grazie ai batteri lattici; nel Sokujo viene aggiunto artificialmente.
-
Manualità e artigianalità: il Kimoto comporta lavorazioni fisiche (come lo Yamaoroshi) e una cura costante; il Sokujo è molto più standardizzato.
-
Prezzo: proprio perché richiede più tempo, lavoro manuale e controllo microbiologico, il Kimoto tende ad avere un posizionamento più alto rispetto ai sake prodotti con Sokujo.
-
Profilo Gustativo: il Kimoto regala maggiore complessità, struttura e profondità rispetto al sake Sokujo.
Caratteristiche sensoriali del sake Kimoto
Un sake Kimoto si distingue nel bicchiere! Alcuni tratti comuni sono:
-
Acidità equilibrata e vivace, che dona freschezza e allunga la persistenza in bocca.
-
Profondità e ricchezza di umami, che lo rendono ideale con piatti saporiti e cucine strutturate.
-
Struttura piena e avvolgente, con un finale persistente e armonioso.
Perché il Kimoto è importante oggi
Oggi il Kimoto rappresenta circa 10% della produzione totale di sake, ma è apprezzato da chi cerca artigianalità, autenticità e complessità sensoriale. I produttori che scelgono di mantenerlo vivo lo fanno non per comodità, ma per fedeltà a un sapere antico e per offrire un prodotto che porti con sé una profondità unica.
Due sake Kimoto da scoprire con Nippo Sakaya
Per chi vuole avvicinarsi a questa tradizione in Italia, ecco due etichette rappresentative:
1. Suginishiki Yasohachi Kimoto Junmai
Un Kimoto dalla prefettura di Shizuoka, caratterizzato da acidità decisa e umami profondo. Complesso, robusto e persistente, è perfetto per accompagnare piatti strutturati come formaggi stagionati, carni bianche o cucina giapponese classica.
2. Ho-no-Ho Kimoto Junmai
Più fresco e diretto, con un equilibrio elegante tra acidità e aromi fruttati. È un Kimoto versatile, ideale anche con piatti mediterranei come pesce grigliato, verdure marinate o formaggi a media stagionatura.

In sintesi
Il Kimoto è un metodo tradizionale di produzione del sake che si distingue dal più comune Sokujo perché non utilizza acido lattico aggiunto, ma si affida a un processo naturale, lento e artigianale. Il risultato è un sake dal carattere unico, con maggiore complessità e profondità rispetto alla maggior parte dei sake moderni.
Spero davvero che tu possa provare i nostri Kimoto selezionati e scoprire di persona questa parte affascinante della cultura giapponese. Kanpai! 🍶
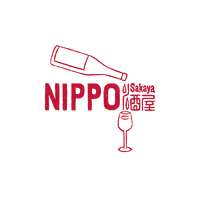







Lascia un commento